Rami Livneh : in carcere ho imparato l'arabo e lo insegno agli israeliani
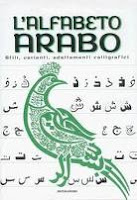
L’esempio del padre, da sempre impegnato a fianco dei palestinesi, e poi l’adesione al Matzpen, gli anni della militanza, l’arresto, la lunga detenzione e infine il ritorno alla vita normale e la scelta di portare avanti le proprie battaglie in modo diverso, inedito: insegnando l’arabo agli israeliani; intervista a Rami Livneh.
La famiglia di mia madre è arrivata in Israele dall’Ungheria all’inizio degli anni ’20, mi sembra nel 1923, lei aveva solo due anni. Mio padre invece era originario della Romania. Dopo aver perso il padre e la madre si era trasferito a Parigi dalla sorella, allora studentessa di medicina. Durante la guerra la sorella, divenuta medico, aveva fatto parte della resistenza francese perdendo la vita.A Parigi mio padre lavorava in un’impresa delle ferrovie e divenne membro del movimento giovanile sionista. Si trasferì in Israele nel 1938, aveva 22 anni. Andò a vivere nel kibbuz Ruhama, dove gli vennero affidati incarichi di responsabilità. Rimase fino al 1944, quando se ne andò per motivi ideologici. Il kibbuz era nel nord del Negev. Già il primo anno mio padre scrisse un articolo polemico sullo slogan del movimento socialista cui anch’egli apparteneva. Il motto era infatti: "Per il sionismo, per il socialismo e per la fratellanza nazionale” e lui ebbe a commentare: "Adesso capisco cosa vuol dire fratellanza nazionale: gli arabi seminano e noi raccogliamo!”. Allora infatti erano stati confiscati i raccolti ai villaggi arabi. Fu così che abbandonò il kibbuz ed aderì all’ala più di sinistra del movimento sionista. Nel 1954 entrò a far parte del Maki, il Partito comunista israeliano, in cui rimase fino alla morte. Quando il partito si divise in due fazioni, una a maggioranza ebraica e l’altra a maggioranza araba e antisionista, aderì a quest’ultima che prese il nome di Rakah. Aveva uno spirito assolutamente internazionalista. Trasferitosi ad Haifa faceva l’operaio in una fabbrica chimica. Quando Emile Habibi, lo scrittore arabo israeliano, decise di lasciare la Knesset, fu mio padre a prendere il suo posto. Habibi aveva iniziato a scrivere moltissimo dopo la guerra del 1967 e nel 1971 si era reso conto che non riusciva a gestire questi due ruoli di scrittore e di attivista politico. C’è un proverbio arabo che dice: "Non puoi tenere due angurie in una sola mano”. E così abbandonò la politica per la letteratura. Questo accadde nel 1972, l’anno in cui venni arrestato: a febbraio mio padre entrò alla Knesset e a giugno io entrai in prigione. L’ironia della sorte. Allo scoppio della guerra del ’67, io avevo subito preso posizione denunciando le responsabilità israeliane. Sapevo che anche l’Egitto aveva avuto un ruolo, ma avevo l’impressione che Israele avesse interesse a non fare accordi con gli stati arabi. Anche durante la prima fase dell’occupazione, mentre facevo il servizio di riservista, non smettevo di discutere con soldati e ufficiali per far valere le mie posizioni e alla fine fui buttato fuori dall’esercito. Ero nei paracadutisti, non mi richiamarono più a fare il riservista.Dopo la guerra il mio impegno politico si intensificò. Nel 1968 aderii a un gruppo di sinistra che si chiamava Matzpen. Era molto piccolo ma faceva molto chiasso: ci battevamo sia in Israele che all’estero contro l’occupazione. Da subito il nostro slogan fu: "Basta con l’occupazione!”; ci consideravano pazzi. Anche se il Matzpen era un gruppo così piccolo, c’erano fortissime differenze di opinione al suo interno: c’erano i maoisti, i trotzkisti, gli anarchici ecc. Alla fine degli anni ’70 iniziammo a interessarci agli sviluppi politici dei movimenti palestinesi. Era l’epoca di "settembre nero”, quando Re Hussein di Giordania aveva espulso dal paese migliaia di palestinesi ed era sorto l'omonimo gruppo. Più o meno negli stessi anni erano sorti il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di Habash (nel 1967) e due anni dopo il Fronte Democratico popolare di Hawatmeh.Sempre nel 1969, avevamo letto con attenzione la dichiarazione di Al Fatah in cui si sanciva che il nemico non era lo Stato ebraico, ma il movimento sionista. Ecco, quello per noi fu un momento cruciale, di svolta. Per la prima volta sentivamo una voce distinta da quella di Shukeiri, primo capo dell’Olp e di quei nazionalisti che sostenevano che gli ebrei andavano tutti buttati a mare. Per la prima volta sentivamo una voce che legittimava, riconosceva i diritti del popolo israeliano in quanto esseri umani. Naturalmente questo non voleva dire riconoscere la politica di occupazione sionistica, ma quella non la legittimavamo nemmeno noi!A quel punto cercammo dei contatti con i palestinesi e, nell’estate del ’70, un mio amico residente in un villaggio arabo, mi disse che un giovane arabo proveniente da Beirut per visitare la sua famiglia nella West-Bank -allora era permesso- organizzava un incontro tra studenti arabi e israeliani appartenenti a formazioni di sinistra. Espressi il mio desiderio di incontrarlo e così avvenne. Discutemmo ininterrottamente per tre ore sulla situazione politica e sulle prospettive. Ci misi un po’ a capire che forse non c’eravamo capiti o semplicemente lui aveva un altro obiettivo. Fatto sta che alla fine della chiacchierata mi disse che "loro” potevano procurarci armi e munizioni. Io risposi che non eravamo interessati ad azioni militari; lui ci propose anche del denaro. Io dichiarai, anche a nome dei miei compagni, che non avevamo bisogno di denaro proveniente da fuori. La nostra linea era che il denaro per un’attività politica locale doveva arrivare dall’area stessa in cui operavamo. Aggiunsi che accettare denaro dall’esterno significava corrompere l’organizzazione politica e creare un legame di dipendenza da chi forniva i soldi. E con questo ci separammo e non ci vedemmo più.Ma la faccenda era tutt’altro che conclusa. Due anni dopo i servizi di sicurezza israeliani individuarono un gruppo composto da ebrei ashkenaziti e di origine medio-orientale, israeliani, arabi musulmani, israeliani cristiani, drusi israeliani. L’organizzazione si chiamava "Fronte Rosso” -i giornali li definirono "la rete ebraico-araba”. Ne faceva parte anche la persona che aveva fatto da collegamento tra me e quel giovane palestinese due anni prima.Già allora si sapeva che io ero politicamente impegnato, ma niente di più. Invece uno dei membri del Fronte Rosso, durante un interrogatorio riferì allo Shin Bet (servizi di sicurezza) della discussione in cui ero stato coinvolto. Così venni arrestato anch’io. L’incriminazione era di aver incontrato un "agente straniero”. Mi condannarono a dieci anni di carcere per quella riunione! All’appello fortunatamente l’accusa di contatto con agente straniero cadde. Tuttavia, siccome secondo la legge avrei dovuto segnalare alla polizia l’uomo che avevo incontrato, mi diedero quattro anni, che non sono comunque pochi.Quando venni arrestato, ero sposato e avevo due bambini piccoli rispettivamente di uno e due anni. Oggi so che fu mia moglie a pagare il prezzo più alto. In fondo, se un essere umano accetta di essere limitato nella sua libertà, può organizzare la sua vita in modo abbastanza soddisfacente; se poi sei un militante politico, accetti più facilmente la tua situazione. Suonerà paradossale, ma devo riconoscere che la mia vita in carcere è stata ricca e interessante. Vivevo insieme a arabi ed ebrei, prigionieri politici e criminali. Io ho anche preso un titolo di studio, ma soprattutto ho imparato l’arabo. Molti dei detenuti arabi volevano imparare l’ebraico e io volevo imparare l’arabo, ci siamo organizzati. Il detenuto arabo che mi ha insegnato l’arabo è stato il miglior insegnante che abbia mai avuto. Quando ne avevo fatto richiesta, si era dichiarato molto onorato. Pur non avendo una specifica competenza professionale, era molto colto e sensibile e capiva quali erano le esigenze dei suoi allievi; mi dava lezioni individuali a orari fissati regolarmente. Eravamo nel carcere di Ramla, le lezioni si svolgevano nelle ore d’aria in cui si aprivano le celle ed avevamo diritto di circolare. Mi ero procurato anche dei libri.In carcere ovviamente ho partecipato alle lotte per migliorare le condizioni di detenzione. Ci fu anche uno sciopero della fame. In quel contesto noi ebrei israeliani lottammo a fianco a fianco con i palestinesi. Uscito dal carcere non me la sentivo di lavorare fuori casa, così per più di un anno feci il "casalingo”; mia moglie, che è fotografa, esercitava la sua professione in un laboratorio. Dopo la scarcerazione lasciai per un po’ la politica. In quel momento era urgente ricostruire i legami affettivi, la mia famiglia. Mi limitai a fare il "soldato semplice” della rivoluzione: partecipavo alle manifestazioni e alle occupazioni, ma non avevo più ruoli organizzativi, tantomeno di leadership. Avevo anche perso la pazienza e l’interesse per quegli eterni dibattiti e discussioni sulle virgole e i punti dei documenti politici.Decisi invece di mettermi a insegnare arabo. Pensai che potesse essere un buon modo per continuare il mio impegno per smantellare quel muro di odio e di non-riconoscimento tra la società israeliana e palestinese. Avevo maturato la convinzione che se si conosce la lingua e la cultura di un popolo è più difficile ignorarlo o addirittura odiarlo. Insomma ho fatto fruttare quello che avevo imparato in carcere e oggi insegno arabo a ragazzi tra i dieci e i quattordici anni a Ramat-Gan, vicino a Tel-Aviv. E’ una scuola "semi privata”, riconosciuta dal Ministero dell’Educazione, parzialmente sovvenzionata dal Ministero e dal Comune. I genitori devono però contribuire alla quota, che non è proprio bassa, soprattutto per chi ha più di un figlio. Infatti la maggior parte degli allievi proviene da famiglie della classe media che si possono permettere questa spesa, ma ci sono anche genitori che, pur non essendo ricchi, credono in questo progetto educativo, e per investirci si sottopongono a dei sacrifici. Qui i ragazzi studiano arabo dal primo all’ultimo livello: all’inizio imparano soprattutto la lingua parlata attraverso le canzoni, i racconti e le filastrocche, poi cominciano a riconoscere le lettere arabe e infine imparano gradualmente a leggere e a scrivere.E’ una scuola particolare, in cui si presta grande attenzione anche alle materie artistiche: ai ragazzi viene insegnata la musica, iniziano a sette anni con il flauto, poi possono scegliere un altro strumento; molti di loro suonano il violoncello, la tromba o il violino. Si fa disegno e pittura, ma anche ricamo, scultura (per lo più in legno), carpenteria. E’ questa oggi la mia battaglia personale: far sì che i giovani ebrei israeliani imparino la lingua e la cultura dei propri vicini. Certo la politica non aiuta, fino a che l’obiettivo resta quello di non concedere niente e anzi di continuare a occupare sempre più territori. Lo Stato israeliano non vuole raggiungere un accordo né con i palestinesi né con i paesi arabi. Non sorprende che il primo accordo sia stato fatto con l’Egitto perché quei territori -il deserto del Sinai- non interessano a nessuno. Si vedrà adesso con la Siria, perché in realtà noi non vogliamo rinunciare alle alture del Golan. Anche con gli abitanti delle colonie si è ormai creato un gioco delle parti: fingiamo che siano i coloni di estrema destra a costringere i politici israeliani a tenere la linea dura con le autorità palestinesi. Ma è tutto un inganno: semplicemente i politici israeliani hanno così buon gioco a dire agli Stati Uniti: "Vedete, non possiamo fare nulla contro la volontà del nostro popolo”.Intanto il governo israeliano dà loro un sacco di denaro -che potrebbe essere impiegato altrove. Per non parlare dell’esercito israeliano che è quotidianamente impegnato a proteggere gli insediamenti. E poi ci vogliono far credere che sono costretti! Figuriamoci: basterebbe togliere loro gli incentivi, ritirare i soldati e il 90% di loro tornerebbe subito indietro, al di là della Linea Verde... Perché il governo israeliano non agisce così? Perché ha interesse a che rimangano.Il futuro? Io continuo a pensare che la soluzione dei due Stati sia l’unica percorribile. Personalmente sarei stato più favorevole all’ipotesi di un unico stato democratico e multiculturale, ma le radici dell’odio e del sospetto tra le due comunità sono così robuste che oggi non lo vedo possibile. La situazione è troppo deteriorata.Qualcuno parla di apartheid. Non so, bisogna capire cosa si intende, perché la situazione sudafricana e quella israeliana sono molto diverse. Se però con "apartheid” si intende che Israele ha creato tre classi di cittadini, con diversi diritti, beh, credo sia difficile negarlo. Oggi ci sono i palestinesi che vivono all’esterno della Linea Verde (nei Territori occupati), poi ci sono i palestinesi israeliani e gli ebrei israeliani. Ebbene, questi tre gruppi godono di diritti diversi, ma proprio per legge, non solo di fatto. In questo senso Israele non è un paese democratico, perché quando il diritto di comprare o vendere la terra è vincolato alla nazionalità, beh, questa è una forma di razzismo. Se poi la discriminazione invade tutti gli aspetti della vita quotidiana per cui il palestinese, ma anche l’arabo israeliano, ha più difficoltà ad accedere alla formazione o al credito o ai permessi di vario tipo, come lo dobbiamo chiamare uno Stato così? Io dico allora che Israele è uno stato razzista. Sull’uso del termine "apartheid” sono invece più scettico. Lo trovo anzi pericoloso, se devo essere franco, perché questo ricorso a termini "forti”, di impatto mediatico, per attaccare Israele mi sembra di dubbia utilità. Questo paese commette cose già molto gravi. Non c’è bisogno di esagerare: basta raccontare ciò che accade. Quasi non c’è bisogno di esprimere dei giudizi. A Gaza sono state usate bombe al fosforo. L’avevano già denunciato i palestinesi, ora l’hanno confermato anche i media israeliani. Parliamo di crimini di guerra. Che altro c’è da aggiungere?Le relazioni tra israeliani e palestinesi purtroppo vanno peggiorando anche a livello di base. Del resto ci sono molte meno opportunità di contatti: non ci sono quasi più palestinesi che lavorano in Israele e gli israeliani non si recano più nei mercati arabi, a Nablus, per esempio: sono ormai due società separate. Oggi l’unica occasione di incontro tra un palestinese e un israeliano è il servizio militare.Questo è triste e paradossale dato che non abbiamo altre prospettive se non quella di vivere assieme.http://www.unacitta.it/newsite/intervista.asp?anno=2010&numero=175&id=2052
Commenti
Posta un commento